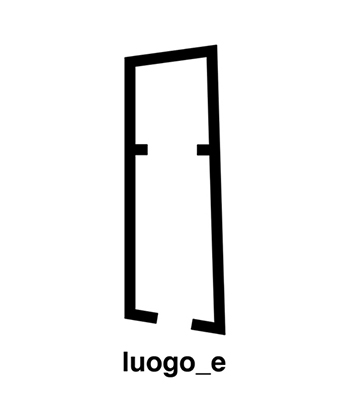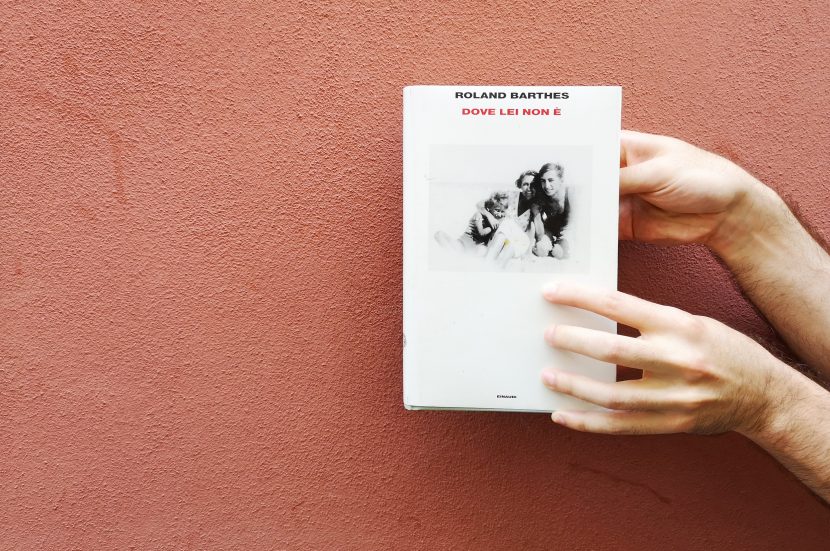(_e pensieri)
Barthes scorreva lentamente quelle vecchie fotografie una ad una osservandole alla luce della lampada una sera di novembre: cercava un’immagine che potesse restituirgli non tanto l’aspetto della madre da poco scomparsa, quanto l’essenza di quel volto amato, l’identità viva della persona cara. Barthes non cercava un’immagine di sua madre, bensì sua madre in un’immagine; voleva ritrovare la malinconia di una presenza, quell’apparizione unica di una lontananza che è possibile identificare con il concetto benjaminiano di aura.
Benjamin aveva opportunamente notato che, sebbene l’avvento della fotografia avesse segnato l’inizio della progressiva affermazione del valore di esponibilità a discapito del valore cultuale, quest’ultimo fosse tuttavia ancora presente nei primi ritratti fotografici dei cari defunti o lontani, nel culto del ricordo di chi non era più fisicamente tra noi. In quei volti amati contemplati intimamente sopravviveva ancora l’aura emanata dal soggetto, come i raggi luminosi dallo stesso emessi e captati dal medium fotografico.
La fotografia analogica è un’emanazione del corpo reale, che instaura appunto un rapporto di analogia tra la luce e il procedimento chimico per fissarla; dall’azione della luce ha origine quel senso di mistero quasi alchemico insito nelle foto analogiche, che conferisce loro il potere di certificare una presenza.
Barthes ritrovò l’essenza dell’amata madre in una vecchia fotografia del 1898, dove posava bambina accanto al fratello tra la vegetazione di un Giardino d’Inverno nella casa natia; nell’espressione dolce e innocente del viso e nell’ingenuità quasi impacciata della posizione delle mani di quella bambina di cinque anni Barthes riconobbe sua madre, ciò che in tutta la sua vita lei aveva significato per lui. Quell’immagine era giusta quanto un ricordo, condensava in sé l’ineffabile giustezza di una sensazione intima.
La fotografia del Giardino d’Inverno viene descritta da Barthes inizialmente in quanto oggetto cartaceo deperibile, una vecchia foto cartonata di un tono smorto color seppia e con gli angoli consumati: è innanzitutto un pezzo di materia, di carta, soggetto a consunzione e invecchiamento; come sottolinea Barthes, essa ha un destino mortale, nasce in camera oscura, si sviluppa, esiste e si deteriora seguendo la sorte del materiale sul quale è stampata.
Il ritratto fotografico è contemporaneamente medium di morte e resurrezione: nella fotografia del Giardino d’Inverno la madre è una bambina che sappiamo ormai essere morta, ma è anche la manifestazione della bambina che è stata, la certificazione di un’esistenza. Attraverso quella particolare compressione del tempo attuata dall’alchimia fotografica, l’immagine diventa una paradossale testimonianza di un defunto vivo e di un vivente morto.
Il verbo “immortalare” racchiude in sé questo ambivalente e indissolubile legame di ogni fotografia con la morte, fosse anche solo la morte stessa dell’oggetto-foto, il suo deteriorarsi. Questo tempo compresso, che rende la madre-bambina contemporaneamente immortale e già morta, è per Barthes il punctum, la manifestazione di un’esistenza che è stata, la cui intensità punge e ferisce lo sguardo.
Come è stato acutamente notato da Byung-chul Han, tanto la fotografia analogica è una cosa, un oggetto del cuore, quanto la fotografia digitale, e nello specifico il selfie, è una non-cosa, un’informazione smaterializzata. La fotografia digitale converte la luce in dati, sostituendo all’alchimia del processo chimico una relazione numerica; in tal modo la foto, sottolinea Han, non è più un’emanazione del referente, diventa bensì autoreferenziale.
Nel selfie scompaiono ogni possibile valore cultuale, ogni aura e ogni legame con la morte, cancellati definitivamente da un valore di esponibilità assoluto e totalizzante. Se il ritratto fotografico è un oggetto da custodire e da osservare intimamente in silenzio, il selfie invece esiste in quanto pura immagine da esibire, da esporre e condividere freneticamente; la contemplazione paziente è scalzata dalla comunicazione istantanea, il selfie è contemporaneamente l’esibizione di un’immagine e l’immagine di un’esibizione, che interviene sul volto mercificandolo. Il selfie è la merce narcisistica da consumare compulsivamente.
La fotografia del Giardino d’Inverno è invece visibile solo da Barthes, che intenzionalmente non la rende mai pubblica, limitandosi a parlarne, a descriverla soltanto: se venisse mostrata si annullerebbe il suo valore cultuale, la magica relazione che la lega al suo proprietario.
Fin dall’antichità, come sottolinea Benjamin, il valore cultuale dell’opera d’arte veniva preservato sottraendola alla vista, mantenendola nascosta e accessibile solo a pochi privilegiati, come i sacerdoti nel caso delle statue degli dèi nella cella del tempio. Ogni esposizione dissolve progressivamente l’aura dell’opera.
Il ritratto fotografico ha un peso, il peso della memoria; esso esiste in quanto oggetto dotato di una sua autonoma presenza, un Altro che si pone di fronte al nostro sguardo, che si contrappone, che oppone resistenza ad ogni possibile fruizione consumistica.
La fotografia analogica genera l’immagine attraverso un processo di sviluppo in camera oscura che richiede un’attesa, un tempo di gestazione; terminato il processo la fotografia esce dalla camera oscura e viene alla luce, nasce come immagine fisica, ritorna a quella stessa luce che l’ha resa possibile durante lo scatto. La foto analogica nasce dal negativo, da una matrice, che è etimologicamente sua mater ed origine: è il risultato di un parto sui generis, una gravidanza chimico-fisica anziché biologica. Il selfie invece produce un’immagine che si presenta con un’immediatezza che cancella ogni attesa desiderante, appare e scompare senza mai arrivare a esistere veramente.
Bibliografia
Roland Barthes, La camera chiara, Torino, Einaudi, 2008.
Walter Benjamin, L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica, Torino, Einaudi, 2007.
Byung-chul Han, Le non cose, Torino, Einaudi, 2022.
Nell’immagine:
Particolare della copertina di Roland Barthes, Dove lei non è, Torino, Einaudi, 2010.
Michele Savino
Ha studiato all’Accademia Carrara di Bergamo e all’Accademia di Brera di Milano.
Scrive, dipinge e coltiva bonsai.